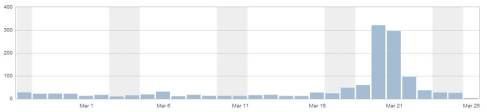Ieri cadeva il centenario di quello che viene considerato l’evento scatenante della Prima Guerra Mondiale, l’attentato a Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco, e questo mi ha portato a ripensare a una persona che non vedo più da un sacco di tempo: fu proprio a un ricevimento dell’arciduca d’Austria che conobbi Jordan Baker.
Non mi fece granché impressione, ero troppo impegnato a chiedermi cosa ci facessi lì per concederle più di un’occhiata superficiale.
Era fasciata in un abito di seta nera pieno di lustrini, e indossava un cappellino che le dava l’aspetto di una cantante blues degli anni ’20. Aveva lo sguardo altero della pupa del gangster, ma non quella frivola che ride sempre per ogni cazzata e alla fine la ritrovano sparata dentro una Morgan, quell’altra, quella con una coscienza che alla fine si redime e lo fa arrestare e si mette col poliziotto buono.
Per la verità i lunghi capelli biondi tradivano quell’immagine retrò nella mia testa, le cantanti blues e le pupe del gangster si pettinavano diversamente, ma non ci feci caso, ero distratto da altre cose, come ho detto; la etichettai come antipatica e passai oltre, lasciandola ad aggirarsi per il salone con un flute di vino fra le dita sottili. Ogni tanto la sua risata squillante echeggiava qua e là, sovrastando il moscio repertorio di valzerini che un quartetto di violinisti pescati in chissà quale festa di quale paesello balcanico si trascinava da ore.
Alcune settimane più tardi mi trovavo sulla Cinquantaquattresima, in pieno centro di Manhattan: ero andato a vedere un appartamento e stavo aspettando l’agente immobiliare davanti a un chiosco ambulante che cucinava piatti messicani, all’angolo con la First Avenue.
Non la riconobbi subito, questa volta indossava un paio di jeans e una camicetta bianca, e nel venirmi incontro sfoderava un sorriso talmente forzato che mi fece venire voglia di andarmene. Non me ne diede il tempo, mi raggiunse con ampie falcate e fece scattare la mano verso di me come la lama di un coltello a serramanico:
“Il signor Renzi? Jordan Baker, molto piacere.”
“Come il campione di pallacanestro?”, domandai, dando subito sfoggio di grande cultura.
“Come un personaggio del Grande Gatsby”, mi gelò lei. I suoi occhi azzurri mi inchiodarono un aguzzo senso di inferiorità appena sotto l’attaccatura dei capelli, e non osai aggiungere altro.
Salimmo a visitare la casa, e mentre mi decantava i vantaggi dei tripli servizi e mi mostrava il letto placido dell’East River dalla grande vetrata dell’ambiente principale, la osservavo di sottecchi.
Era carina, se non avesse avuto quei modi affettati da venditrice mi sarebbe piaciuto passarci un po’ di tempo insieme, a cercare di capire se era più forte il fastidio per i suoi modi esageratamente cordiali o l’attrazione che mi provocavano i suoi occhi, di un azzurro slavato, come il ghiaccio che si forma in certe grotte artiche.
Alla fine non comprai l’appartamento, era troppo grande per viverci da solo, e poi i vicini erano una famiglia di italiani veramente molesta, lei friggeva tutto il giorno, lui suonava la chitarra e i due bambini strillavano senza sosta. Jordan Baker invece meritava una seconda impressione, e la invitai a fermarsi per un caffè.
Accettò, aveva ancora un paio d’ore prima dell’appuntamento successivo e il cielo minacciava pioggia. Solo che non c’erano bar nei dintorni, e quelli che c’erano erano chiusi, e quelli che non erano chiusi erano frequentati da bande di mafiosi motociclisti drogati, che seduti sulle loro harley pretendevano dai clienti il pizzo, ma in spiccioli, e nel frattempo sgasavano davanti al bancone.
Ci restava solo il messicano ambulante, così facemmo conoscenza davanti ai peggiori burritos della mia vita, quelli serviti da Wang Chang Gonzales: cucina messicana cantonese.
“Che lavoro fai?”, mi chiese.
“Nessuno. Sono il protagonista bidimensionale di un racconto, vivo episodi slegati da un contesto per venire incontro alle esigenze di un autore privo di fantasia. Pensa che qualche settimana fa ero a Vienna, al ricevimento di un personaggio morto da un secolo. Fra l’altro sono quasi sicuro di avertici incontrata, è possibile?”
“Si, ero io: i grandi sconvolgimenti internazionali sono una manna per noi agenti immobiliari, si liberano di colpo un sacco di proprietà, a muoversi in tempo c’è da concludere ottimi affari.”
Non mi tornava, l’Arciduca d’Austria era ancora vivo la sera del ricevimento, come faceva questa qui a sapere che il suo assassinio avrebbe scatenato la più sanguinosa guerra di tutti i tempi?
“Beh, vedi”, mi rispose, “la concorrenza è agguerrita, e certe volte siamo costretti a prendere contatti con il venditore prima ancora che sappia di esserlo.”
“Va bene, ma come si fa a sapere chi venderà casa sua se neanche lui ha ancora deciso di venderla, scusa?”
“Certi equilibri sono così precari che se sai dove toccare basta una spintarella per far venire giù tutto. Diciamo che io mi occupo di spintarelle.”
“Ma.. mi stai dicendo che quell’anarchico serbo..”
“Mio cugino Riccardo.”
“Tu sei una donna pericolosa”, dichiarai ammirato. “E bella.”
“E anche un po’ stronza, lo ammetto.”
“Le donne belle e stronze esercitano su di me un fascino irresistibile. Mi lasci il tuo numero di telefono?”
Dopo il secondo caffè eravamo ancora lì a raccontarci cose, ma Wang Chang Gonzales ci chiese di liberare il banco, che la polizia era già passata diverse volte e lui non aveva il permesso per occupare il suolo pubblico, doveva telare.
Io però non avevo il numero di Jordan, e mi seccava di apparire troppo insistente.
“Senti, dove hai l’appuntamento? Magari ti accompagno, ho la macchina qui dietro.”
“La macchina in centro a Manhattan deve costarti una fortuna, come fai?”
“Ma no, è solo una diceria, in realtà è molto vantaggioso!”, risposi, spaccando il vetro di una Ford parcheggiata lì accanto.
Ovviamente fu un viaggio lunghissimo, girare per Manhattan non è neanche troppo difficile per chi è allenato ai sensi unici impossibili di Genova, ma io mi trovavo lì da non più di una pagina, e di certo non ci avevo mai guidato. Senza contare che il cambio automatico mi dà in culo da morire.
Dopo due ore ci trovavamo ancora all’angolo fra la Broadway e la Ventiduesima, in direzione ovest.
“Non sono sicura che questa sia la strada giusta, però”, mi disse la passeggera.
“Dove hai l’appuntamento?”
“Parigi. Davanti alla metro di Abbesses.”
“Mi sa che farai tardi”, mi rammaricai.
“Non fa niente, è stato un bellissimo viaggio. Magari prendo un taxi.”
Abbandonai la macchina in mezzo alla strada e mi avvicinai al primo taxi che si fermò a strombazzare arrabbiato. Aprii la portiera e feci accomodare Jordan Baker, poi restai lì a guardarla, con lo sportello in mano, incapace di chiudere l’incanto.
“Posso rivederti?”, le chiesi.
“Certo!”, disse, e sorrise, e i clacson furibondi intorno tacquero di colpo.
Come non dipingerei mai uno svincolo autostradale su un paesaggio di Monet, così non mi sentii capace di rovinare la poesia di quel momento con una domanda prosaica come il suo numero di telefono: restai lì a guardarla andare via su un taxi guidato da un sikh col turbante. Una ragazza dai capelli biondi, con una camicetta bianca, su un taxi giallo. Il turbante era rosso. E io non lo saprei disegnare, uno svincolo autostradale, Monet o meno.
2.
Per un po’ cercai di rivederla contattando tutte le agenzie immobiliari della città; credo di avere visitato ogni appartamento dal Bronx a Staten Island, se avete intenzione di comprare casa da quelle parti chiedete pure a me. Tutto inutile, Jordan Baker era scomparsa, e la cosa peggiore era che nessun agente sembrava conoscerla, era come se fosse uscita da una scatola per regalarmi quel bellissimo pomeriggio e e poi sgattaiolare via con la mia anima sottobraccio.
Alla fine rinunciai e tornai alla mia solita vita, che però non avevo, essendo un personaggio creato apposta per questo racconto. Trascorrevo le giornate ciondolando per la città, dentro e fuori dalle librerie dove compravo vecchi tascabili dalle pagine stropicciate, mi fermavo a mangiare in certe trattorie giapponesi sconsigliate dalle guide turistiche, per vedere se è vero che ti danno da mangiare il pesce palla velenoso. A pensarci adesso era un’idea del cazzo, meno male che non ne ho mai trovato nessuno. Una sera ero in una stazione della metropolitana nell’Upper West Side, ad ascoltare un nero con la tromba che sapeva fare tutto Kind Of Blue di Miles Davis, uguale preciso a lui.
Eravamo una decina ad assistere a quella meraviglia, ogni tanto si fermava, qualcuno gli buttava un paio di dollari e lui riattaccava, come un juke box con un disco solo. C’era una ragazza bassina, un vestito piuttosto corto che le lasciava le gambe scoperte, e un paio di scarpe col tacco. Portava un panama sui capelli neri e teneva le spalle in avanti, come se Miles Davis le avesse riportato in mente qualcosa di doloroso. Ogni tanto un tic nervoso le chiudeva un occhio, non dava l’impressione di una persona serena che si stava godendo il concerto.
Mi avvicinai, sono sempre stato attratto dal subbuglio interiore, e poi era carina, e io non avevo niente da fare. Si, indossava degli occhiali dalla montatura pesante, come voleva la stupida moda di quel periodo, ma più la guardavo più la trovavo piacevole, semmai ci fossimo sposati le avrei chiesto di mettere delle lenti a contatto. Ad un certo punto si mosse per buttare una manciata di spiccioli nell’astuccio del musicista, e inciampò franando addosso a un tizio pelato in camicia celeste, probabilmente un impiegato di ritorno dall’ufficio.
La ragazza con gli occhiali da hipster si scusò con impeto, ma il tizio non sembrava essersela presa, tutt’altro: le restituiva occhiate generose alla scollatura del vestito e l’aiutava a ricomporsi con manate troppo amichevoli. Lei cercò di divincolarsi, ma quello aveva mani dappertutto e non voleva proprio saperne di smettere. Ad un certo punto perfino il nero con la tromba gli aveva detto di piantarla, ma il tizio gli aveva risposto secco di farsi i cazzi suoi Duke Ellington, dimostrando grosse carenze di cultura musicale. Il nero con la tromba era diventato un nero incazzato senza tromba e gli si era buttato addosso. Per il pubblico non faceva alcuna differenza se assistere a un concerto jazz o a un incontro di lotta libera, ma la ragazza si era messa a urlare come un’indemoniata: “pervertito di merda!” al tizio che la palpava, “negro di merda!” al musicista e “americani di merda!” al pubblico indifferente.
La situazione era critica, presi la ragazza per un braccio e la tirai via, prima che qualcuno potesse offendersi e allargare la rissa oltre i due che ancora si dimenavano sul marciapiede.
“Si può sapere che problemi hai?”, le chiesi mentre la tiravo. Lei assumeva pose da contorsionista e cercava di colpirmi con una borsa di tela che recava il marchio di una libreria del centro. Conoscevo quel negozio, ci si comprava bene.
“Lasciami!”, strillava, e avrebbe attirato l’attenzione di qualche altro musicista di animo nobile, perciò la lasciai. Ne approfittò per colpirmi con la borsa: vendevano anche libri belli pesanti, in quel negozio.
“Ma che cazzo fai?”, ci chiedemmo all’unisono.
“Io? Tu, piuttosto!”, rispondemmo. Poi l’assurdità del dialogo ci apparve chiara, e finimmo a ridere in un bar.
Si chiamava Luna, che in quanto a nomi di merda è secondo solo a Zuleika, era messicana e si, era nervosa e triste e quel disco lo aveva regalato al suo ex fidanzato per il loro anniversario, e da tre settimane si erano lasciati, e lei navigava a vista in quelle acque insidiose che separano il momento in cui esci da una relazione e quello in cui smetti di credere che possa ricominciare, quando cerchi di dimenticare quel che è stato e ti ripeti ogni due minuti che è finita, ma senza provarci davvero, come se anche la sofferenza fosse un modo di prolungare la vostra storia.
“Lo sapevo che me ne dovevo andare, che mi stavo facendo male, ma volevo stare lì e prendermele tutte in faccia quelle note, volevo darmi una scusa per tornare a casa e piangere ancora.”, mi raccontò, e la sua risata di prima chissà dov’era sparita, ed era un peccato, che aveva una bella risata, anche se i denti erano tutti accavallati uno sull’altro, quando ci batteva il sole sopra sembrava una foto di Santorini. E gli occhiali da hipster, non dimentichiamolo. Pensai che non ne avrei fatto la donna della mia vita, soprattutto dopo avere conosciuto uno splendore come Jordan Baker, ma farla ridere si, potevo riuscirci, e le raccontai una serie di cazzate una peggio dell’altra che avevano costellato la mia vita sentimentale.
Le parlai di quando un tizio geloso mi aveva telefonato per minacciarmi, ma la linea era disturbata, e non c’è che ammazzi la tensione come uno che ti chiede continuamente di ripetere e si scusa perché non riesce a capire cosa vorresti spaccargli.
Le dissi che una volta avevo scritto una lettera bellissima a una ragazza e gliel’avevo infilata di notte nella cassetta della posta, ma avevo sbagliato cassetta, e il giorno dopo mi telefona uno che vuole conoscermi, che lui parole così dolci non non le aveva mai ricevute, e neanche quella volta lì, gli dico io, e la cosa non era proseguita, ma mi ero fatto delle domande.
Raccontai di una ragazza che mi aveva invitato a dormire a casa sua una sera, e mentre dormiva mi ero alzato e le avevo riempito la libreria di bigliettini carini, e altri ne avevo nascosti in bagno, e nell’armadietto delle pentole, e fra i tovaglioli, e sotto la cassetta dei gatti, dietro i quadri in corridoio, sotto i cuscini del divano, pensando che sarebbe stato bello che nel corso dei suoi giorni futuri ci fosse inciampata dentro: me l’ero immaginata felice di quel regalo inaspettato, e pensavo che sarebbe stata una bella scusa per telefonarmi ancora e piano piano innamorarsi di me. Solo che una settimana dopo si era rimessa col suo fidanzato, e alla fine mi aveva si, telefonato, ma per insultarmi, che i bigliettini carini li stava trovando tutti lui e ogni volta scoppiava la guerra.
Luna rideva e a vederci da fuori sembravamo proprio due persone felici, solo che quello che vedi da fuori non corrisponde mai alla verità, e quante coppie conosci che si portano sotto il sorriso una distesa di fango e ci affondano sempre di più, ma non smettono di sorridere neanche per un minuto, che poi la gente chissà che pensa. Lei il fango sotto le scarpe ce l’aveva davvero, te ne accorgevi subito, si accendeva una sigaretta dietro l’altra, le spuntava questo tic all’occhio, e quando le sembrava che fossi distratto abbassava lo sguardo e incassava le spalle e sospirava.
Io con le scarpe sporche ci sono nato, mi sento sempre fuori posto e mi dibatto fra la voglia di osare e la sicurezza del mio orticello. Per essere un personaggio bidimensionale sono fin troppo complicato.
“Ti piace il mare?”, le domandai.
“Mmm”, rispose, e mi lanciò un’occhiata sospettosa. Credo si aspettasse un invito, e mi stava già pesando come quello che dopo dieci minuti è già lì che ci prova.
“A me il mare piace, ma sono di quelli che al mare stanno sempre dove si tocca.”, le dissi.
“So nuotare, non è quello, ma tutto quell’ignoto che mi si apre sotto i piedi è troppo spaventoso da affrontare, mi mette ansia pensare a quante cose possono nascondersi dove non si vede più il fondo. Sarebbe bello essere un palombaro e camminarci in mezzo a quell’ignoto, non sarebbe più ignoto, e avrei un bello scafandro pesante a proteggermi, ma non sono un esploratore degli abissi e me ne sto nell’acqua bassa, nuoto avanti e indietro sognando di trovarmi in mezzo all’oceano, nessuna traccia della riva in nessuna direzione, solo io e il mare.”
Adesso Luna mi guardava con la faccia di quella che non ha capito dove stai andando a parare.
“Quando il sogno si fa troppo reale”, continuai, “e mi prende l’angoscia non devo fare altro che allungare le gambe, e la sabbia sotto le dita mi restituisce subito la tranquillità. Però questa cosa non va bene.”
“È tutta una metafora elaborata per dirmi che bisognerebbe osare di più? Mi sembri uno da metafore complicate tu.”
“Sto dicendo che non puoi chiuderti in un guscio di noce e sentirti il re di uno spazio infinito, perché alla fine sei solo il re del tuo cazzo di guscio di noce. Che non ci sarebbe niente di male ad accontentarsi, ma non ce la faccio, continuo a sognare di andarmene, sono felice solo ogni tanto, e come fai ad essere felice a singhiozzo, nessuno la merita una miseria così.”
“Non te la passi bene nemmeno tu, eh?”
“Finisci per chiuderti in una gabbia per tenere fuori le cose brutte, te ne scegli una grande, gironzoli un po’ e piano piano ti crei l’illusione di essere libero, ma non ci si può vivere bene in una gabbia, anche se è bella grande: prima o poi arrivi a toccare le sbarre, e l’illusione crolla, e cosa fai?
Puoi voltarti e rimetterti a camminare nella direzione opposta, o sederti dove non si vedono le sbarre e decidere di rimanere lì, ma in quel modo ti crei solo un’altra gabbia più piccola.”
Non so da dove mi fosse uscito tutto quel malessere, un attimo prima stavo ridendo delle mie sfighe, quello dopo ero in pieno trip psicanalitico e facevo a cazzotti con la mia infelicità cronica.
Ci guardammo per un po’ in silenzio, era chiaro a tutti e due che in quel bar non si stavano mettendo le basi per una storia interessante, quello era il funerale della serenità. Ci salutammo fuori dalla porta e quando mi guardai intorno vidi solo una distesa di palazzi senza significato, e macchine che non andavano in nessun posto, e capii che era venuto il momento di tornare a casa.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...